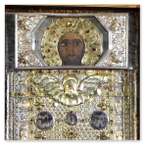Racconti
Tradizioni
Molte vicende legate alla storia delle chiese di Roma hanno generato tradizioni che hanno resistito al passare dei secoli. Spesso queste tradizioni sono diventate un patrimonio che riflette non solo la storia, ma anche la vita quotidiana dei romani. Soprattutto alcune feste religiose spesso hanno una matrice popolare profana legata alla convinzioni di dover esorcizzare le forze del male e propiziarsi quelle del bene.
La Colonna infame-San Bartolomeo all'Isola
Al centro dell’Isola Tiberina, di fronte alla chiesa di San Bartolomeo, dove ora si trova una guglia con alla base statue di santi, sorgeva una colonna, che era detta Colonna infame poiché il 24 agosto di ogni anno (giorno dedicato a S. Bartolomeo) ad essa rimanevano affissi per otto giorni consecutivi i nomi di coloro che durante la precedente Pasqua non avevano rispettato il precetto di confessarsi e prendere la Comunione. Nel 1867, sotto il pontificato di Pio IX, accadde che, accidentalmente, la Colonna infame fosse investita da un carro e cadesse a terra, frantumandosi; ma non andò persa l’usanza di esporre al pubblico ludibrio i nome dei renitenti al precetto pasquale, che continuarono ad essere affissi nel pronao della chiesa di San Bartolomeo fino al 1870, anno della Breccia di Porta Pia che provocò la caduta del potere temporale del Papa.
La pigna dei diavoli-Santa Maria ad Martyres
In Santa Maria ad Martyres-Pantheon, il giorno di Pentecoste, si ripete ogni anno un rito antico, detto la Pasqua delle rose: alla fine della Messa, una pioggia di petali di rosa viene fatta cadere sui fedeli dall'oculus al centro dell'enorme cupola, per commemorare la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Una leggenda dice che il foro della cupola in antichità era sigillato con una grande pigna di bronzo che i diavoli avevano trasportato a Roma, e che quando papa Bonifacio consacrò il Pantheon come chiesa, gli spiriti maligni fuggirono dall’oculus, portandosi dietro la pigna.
La scalinata della fortuna-Santa Maria in Aracoeli
La costruzione della scalinata in marmo di 124 gradini, risalente al 1348, fu commissionata come voto alla Vergine per la fine dell’epidemia di peste che imperversava in tutta Europa. Fu realizzata con marmi ricavati dalla scalinata del Tempio di Serapide al Quirinale e fu, poi, inaugurata dal tribuno Cola di Rienzo. Era considerata una vera e propria Scala Santa. La scalavano in ginocchio le zitelle in cerca di marito, le donne che volevano un figlio, le mamme che chiedevano latte per i propri figli, e anche chi desiderava vincere al Lotto. In quest'ultimo caso la tradizione voleva che, per ottenere i numeri vincenti, fosse necessario salirla in ginocchio di notte, recitando Avemarie e De profundis e raccomandandosi ai Re Magi.
Gli agnellini del Papa-Sant'Agnese fuori le mura
Il 21 gennaio, in occasione della festa di S. Agnese, durante la messa solenne del mattino, vengono posti sull'altare, che sorge sopra la tomba della martire, due agnelli coronati, uno di fiori bianchi per sottolineare la verginità della santa, l'altro di fiori rossi che ne ricordano il martirio.
Gli agnelli, donati dai monaci trappisti dell'Abbazia di San Paolo alle Tre Fontane e adornati dalle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, arrivano in basilica per la benedizione accompagnati da due canonici di San Giovanni in Laterano. Successivamente vengono presentati al papa come atto di fedeltà del Laterano al Papa per concludere il loro pellegrinaggio presso il monastero delle Monache Benedettine di Santa Cecilia, che provvedono con la loro lana a confezionare i pallii che il Pontefice indossa in ogni celebrazione e che impone agli arcivescovi metropoliti il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo.
La dote alle zitelle-Santa Maria sopra Minerva
Nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva un tempo si svolgeva il rito della “processione delle zitelle”. Si trattava di una cerimonia per la consegna della dote alle giovani ragazze che volevano sposarsi oppure entrare in convento. Era rivolta per lo più di adolescenti provenienti da famiglie povere o di dubbia moralità; le ragazze dovevano essere di gradevole aspetto e residenti a Roma da almeno due anni. Queste giovani, scelte tra tutti i rioni della città, il 25 marzo di ogni anno, in occasione della festa dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria, si riunivano in piazza Santa Chiara, vestite di bianco e con un velo che lasciava scoperti solo gli occhi, erano infatti chiamate le “Ammantate”, a due a due e con una candela accesa in mano, in processione raggiungevano la Chiesa di Santa Maria sopra Minerva. A conclusione della solenne messa papale, le ragazze andavano a genuflettersi dinanzi al Papa e, dopo il bacio della Sacra Pantofola, veniva consegnato loro un sacchetto di seta bianca con una dote di 50 scudi per quelle che intendevano prendere marito e di 100 scudi per quelle che intendevano prendere il velo. Questo singolare rituale era nato con l’intento di dare una seconda possibilità alle povere e bellissime romane che, proprio per la loro avvenenza e le loro scarse risorse economiche, rischiavano di finire vittima del mercato della prostituzione. Nel 1872, dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia, il rito del conferimento della dote alle “zitelle” fu abolito.
La processione delle vedove-San Vitale e Compagni Martiri
Nel 590, dopo una inondazione del Tevere che distrusse gran parte della città, ci fu una terribile epidemia di peste che sterminò gran parte della popolazione. Papa Gregorio Magno invitò il popolo alla preghiera istituendo una litania septiforme, chiamata così perché era formata da sette cori, composti rispettivamente dal clero, abati e monaci, badesse e le loro congregazioni, i bambini, i laici, le vedove, le donne sposate. Ciascuno di questi cori partiva in processione da una chiesa diversa fino alla tappa finale nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il sesto coro, quello delle vedove, partiva proprio dalla basilica di San Vitale.
Durante una di queste processioni, organizzata da S. Gregorio Magno, si verificò l’apparizione salvatrice dell’arcangelo Michele sulla Mole Adriana (oggi Castel Sant’Angelo) nell’atto di sguainare la spada, segno della fine dell’epidemia.
Il miracolo della neve-Santa Maria Maggiore
La tradizione vuole sia stata la Madonna stessa ad ispirarne la costruzione apparendo in sogno a papa Liberio e al patrizio Giovanni e suggerendo che il luogo adatto sarebbe stato indicato in forma straordinaria. Così quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata imbiancò l'Esquilino, il papa Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della nuova basilica, costruita poi grazie al finanziamento di Giovanni. Da questa tradizione derivano i nomi di basilica Liberiana e di Santa Maria ad Nives usati in passato per citare la basilica.. Il 5 agosto di ogni anno, in ricordo dell'evento prodigioso, avviene la rievocazione della "nevicata" attraverso una celebrazione in cui viene fatta scendere nella piazza antistante una neve artificiale, “sparata” da quattro cannoni appositamente predisposti.
La benedizione delle auto-Santa Francesca Romana
Dopo il riconoscimento a S. Francesca Romana del Patronato degli automobilisti, attribuito da Papa Pio XI in occasione dell’Anno Santo 1925, la benedizione delle automobili al Colosseo, presso l’area dell’Arco di Costantino, è la più antica tradizione romana legata al mondo dell’automobile che si perpetua dal 1928. Il 9 marzo, di ogni anno, nel giorno dedicato a S. Francesca Romana, patrona degli automobilisti, si svolge dal 1928 presso la basilica il raduno e la benedizione delle automobili e, in generale, di tutti i veicoli a motore, sia di privati cittadini che di istituzioni pubbliche.
La benedizione degli animali-Sant'Eusebio all'Esquilino
Ogni anno il 17 gennaio, davanti alla chiesa di Sant'Eusebio, all'angolo tra via Napoleone III e piazza Vittorio, si rinnova una tradizionale quanto curiosa funzione: quella della benedizione degli animali. Il rito è celebrato oggi in forma assai ridotta rispetto al passato e i partecipanti si sono ristretti ai soli animali domestici come cani, gatti e canarini. Nei secoli scorsi, la cerimonia si svolgeva invece con grande sfarzo: gli animali da benedire erano numerosissimi e andavano dai buoi agli asini, dagli animali da cortile fino ai cavalli delle carrozze dei nobili. La benedizione, poi, aveva luogo in origine nella vicina chiesa di Sant'Antonio Abate, il santo protettore degli animali, e solo quest'ultimo secolo è stata dirottata, per motivi di traffico, a Sant'Eusebio.
Il protettore delle donne-San Pasquale Baylon
La tradizione popolare considerava S. Pasquale Baylon il protettore delle donne, in particolare delle zitelle, tanto che l’omonima chiesa di Trastevere era conosciuta come chiesa delle zitelle, che si rivolgevano al santo in cerca di marito, con una conosciuta preghiera:
“S. Pasquale Baylonne protettore delle donne
deh, trovatemi un marito bianco, rosso e colorito
ma di certo a voi uguale o glorioso S. Pasquale.”
Il santo non era solo considerato il protettore delle zitelle, ma anche di tutte quelle donne che a lui si rivolgevano a causa dei mariti che incontravano difficoltà nell'adempimento dei loro doveri coniugali. La tradizione, inatti, vuole che a una di queste donne il santo sia apparso in sogno e le abbia dettato una ricetta per un liquore che avrebbe vinto la mancanza di desiderio del marito: una crema fatta con zucchero, uova e vino Marsala. La crema fu chiamata, in onore del santo, il “San Bayon”, poi “sambaione” e infine “zabaione”. Per questo S. Pasquale Baylon è diventato anche il patrono dei pasticceri.
San Giuseppe frittellaro-San Giuseppe dei Falegnami
Il personaggio di S. Giuseppe è sempre stato molto venerato dal popolo romano. Di questo sono testimonianza le tante chiese costruite a Roma in suo onore, e la grande diffusione del nome Giuseppe o Giuseppina tra la gente. Per questi motivi il 19 Marzo è sempre stata una data particolare a Roma. Infatti, la festa di S. Giuseppe è sempre stata accompagnata da grandi festeggiamenti: nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al Foro, la confraternita dei Falegnami organizzava solenni festeggiamenti e banchetti a base di frittelle e bignè alla crema, da cui il detto romano "San Giuseppe frittellaro". Momento clou della festa era proprio l'invasione nelle strade dei friggitori che celebravano in versi la bontà delle proprie frittelle, in grado addirittura di far tornare la vista ai ciechi, la parola ai muti e persino di far camminare gli storpi: "E chi vuol bene mantenersi sano / di frittelle mantenga il ventre pieno”. Di quella che agli inizi del secolo era una grande festa popolare, è rimasto negli anni recenti solo un pallido ricordo nel quartiere Trionfale.
Le pagnottelle delle Clarisse-San Lorenzo in Panisperna
La denominazione della chiesa di San Lorenzo nel rione Monti come "in Panisperna" compare per la prima volta nel dodicesimo secolo. L'origine del toponimo Panisperna, con il quale si identifica oltre alla chiesa anche la via che congiunge via Quattro Novembre con via Urbana, trova origine nella tradizione popolare legata alla dispensa ai poveri di Panis et Perna (pane e prosciutto) da parte delle Ciarisse che custodirono per secoli la chiesa di San Lorenzo. Questa antica tradizione, che: si rinnovava ogni dieci agosto in occasione della ricorrenza del martirologio del Santo, avrebbe, a sua volta, avuto origine dall'usanza pagana di mangiare "pane e prosciutto" durante le feste pagane celebrate in onore di Giove Fagutale sul vicino Colle Esquilino.
La Madonna Fiumarola-Sant'Agata in Trastevere
Una leggenda narra che alcuni pescatori, verso la metà di luglio dell’anno 1535, dopo una furiosa tempesta, nei pressi della foce del Tevere rinvennero una statua scolpita in legno di cedro della Vergine Maria. Affascinati dalla bellezza della statua della Vergine, si affrettarono a trasferirla nella chiesa di sant'Agata a Trastevere, dove ancora oggi risiede. Da subito chiamata la “Madonna Fiumarola”, è la protettrice dei romani trasteverini, che ogni anno la omaggiano, il primo sabato dopo il 16 luglio, giorno della festa liturgica della Madonna del Carmelo. La statua della Vergine, ricoperta di gioielli e abiti preziosi, viene portata in processione per le strade di Trastevere fino alla chiesa di San Crisogono, dove rimane per otto giorni per poi tornare poi nella chiesa di Sant’Agata.
La festa della Madonna del Carmine, a Roma, ha assunto nel tempo delle connotazioni particolari, divenendo intorno agli anni Venti, anche "la festa de noantri” a cui partecipa tutto il rione Trastevere con bancarelle, mercatini, osterie aperte a tutti i passanti, manifestazioni e teatri ambulanti, che attirano l'attenzione di curiosi e turisti. Un insieme di tradizione popolare, storia, fede, arte che converge nella statua della “Madonna Fiumarola”.
La notte dell streghe-San Giovanni in Laterano
Una delle feste religiose e profane più sentite a Roma era quella di San Giovanni, patrono della città, il 24 giugno. La festa cominciava la notte della vigilia, la cosiddetta “notte delle streghe”, durante la quale la tradizione voleva che le streghe andassero in giro a catturare le anime. Era credenza popolare, infatti, che in quella notte i fantasmi di Erodiade e di sua figlia Salomè che avevano fatto decapitare il Battista e per questo condannate a vagare per il mondo su una scopa per espiare la colpa, chiamassero a raccolta tutte le streghe sui prati del Laterano.
La gente partiva da tutti i rioni di Roma, al lume di torce e lanterne, e si concentrava a San Giovanni per pregare il santo e a mangiare le lumache nelle osterie e nelle baracche predisposte per la festa. L’usanza del mangiar lumache era prassi, perché la tradizione voleva “tante lumache, tante corna per le streghe”. La partecipazione popolare era massiccia, si mangiava e si beveva in abbondanza e soprattutto si doveva far rumore con trombette, campanacci, tamburelli e petardi di ogni tipo. Con questi rumori assordanti, secondo l’antica usanza, si potevano impaurire ed allontanare gli spiriti del male e le streghe.
La festa si concludeva all'alba quando il Papa, dopo lo sparo del cannone di Castello, si recava a San Giovanni per celebrare la messa alla presenza delle autorità religiose e politiche.
I pani di San Biagio-San Biagio degli Armeni
San Biagio da Sebaste è stato un medico e vescovo armeno vissuto tra il III e il IV secolo in Asia Minore. A causa della sua fede cristiana venne imprigionato dai Romani e condotto al martirio. La tradizione narra che, poco prima dell'esecuzione, una donna gli abbia chiesto di salvare il figlio che stava soffocando a causa di una lisca di pesce conficcata in gola. San Biagio gli diede una grossa mollica di pane che lo aiutò a ingerire il corpo estraneo, salvandolo.
La chiesa in via Giulia, a lui dedicata, fin dal XIV secolo è più popolarmente nota a Roma come San Biagio della Pagnotta, dal pane che i monaci distribuivano ai poveri e che ancora oggi viene offerto ai fedeli in forma di piccole pagnotte benedette nel giorno della festa del santo, il 3 febbraio. Nella stessa occasione, è esposto alla devozione un frammento della gola del martire, custodita per la restante parte dell’anno al Vaticano, nel Tesoro di San Pietro. San Biagio è considerato il protettore dei malati che chiedono guarigione per le malattie della gola.
La processione de "le panze"-Santa Maria in Campitelli
Nel corso dei secoli passati, a Roma non c’era chiesa, oratorio o confraternita che nell’arco dell’anno non facesse una processione. Una delle più curiose era la cosiddetta "processione de “le panze", cioè delle partorienti, che si svolgeva il 26 luglio, giorno della festa liturgica di S. Anna. Organizzata dalla Confraternita dei Palafrenieri, la processione vedeva riuniti davanti alla chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli tutti i partecipanti. Qui, le future mamme ricevevano una candelina che, se accesa durante le prime doglie, avrebbe protetto genitrice e bambino, facilitando il parto e rendendolo più rapido e sicuro. Secondo la credenza, infatti, il lieto evento si sarebbe compiuto "entro la durata della candela". Le donne incinte sfilavano, precedute da rullo di tamburi, avvolte in mantelli che ne nascondevano il viso e con la candela in mano; chiudeva la processione una statua di S. Anna con la Madonna. Quando la lunga fila giungeva su ponte Sant’Angelo il cannone di Castello salutava la Vergine con colpi di artiglieria a salve. La processione si concludeva nella chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri in Vaticano, sede della Confraternita.
Modi di dire della tradizione-Santi Andrea e Gregorio al Celio
San Gregorio al Celio è una delle chiese più venerate dal popolo romano e il suo nome ricorre anche in due modi di dire tradizionali che vale la pena di citare.
So' finite le messe a San Gregorio. Usata anche come proverbio, l'espressione significa: "Non c'è altro da fare, la pacchia è finita". Secondo l'ipotesi più accreditata, il modo di dire deriva dal privilegio di età remota concesso alla Chiesa di San Gregorio di dire messa un'ora dopo mezzogiorno, per consentire ai ritardatari di prendervi parte. Dopo quella, non c'erano altre messe.
Cantà le messe a San Gregorio. Vuol dire: "Risolvere tutto pagando un sovrapprezzo" e fa riferimento alla famosa messa gregoriana che, grazie alle speciali indulgenze, aveva il potere di liberare l'anima del defunto dal Purgatorio e di inviarla direttamente in Paradiso. Per tale ragione, le messe di suffragio che venivano celebrate sull'altare di San Gregorio costavano il doppio di quelle comuni.
Avecce er gregorio. Il termine “gregorio” usato nel senso di fortuna, deriva dal fatto che San Gregorio, insieme all’immaginario San Culàzzio, era il protettore delle persone fortunate al gioco. Infatti, per indicare una situazione particolarmente propizia si dice anche “avecce San Gregorio pe’ protettore“.
La sedia "stercoraria"-San Giovanni in Laterano
Nel corso dei secoli sono nate molte leggende intorno alla figura dei pontefici; la storia della sedia stercoraria, però, non è una leggenda ma una realtà che è durata dall’epoca medievale fino all’elezione al soglio pontificio di Leone X, nel secolo XVI.
Quando il nuovo vicario di Cristo veniva eletto al soglio di Pietro doveva adempiere alcuni riti nella basilica vaticana, finiti i quali si recava al Laterano dove aveva luogo l’intronizzazione che prevedeva altre cerimonie, tra le quali quella della sedia stercoraria sulla quale il neoeletto doveva sedersi in segno di umiliazione.
Invece una leggenda popolare voleva che la ragione di questa cerimonia andasse ricercata nel fatto che occorreva esaminare il sesso dell’eletto dopo l’inganno della papessa Giovanna, una donna in realtà mai esistita che, secondo la leggenda, sarebbe riuscita a salire al soglio pontificio nascondendo la propria identità; ad evitare, quindi, l’eventuale frode che di nuovo una donna sotto mentite spoglie potesse sedere sulla cattedra di Pietro. Da qui, la sedia, dotata di un foro centrale, avrebbe avuto la funzione di confermare la mascolinità del nuovo papa. In realtà il rito simboleggiava l'umiltà umana e la sua fragilità, ricordando al pontefice che, nonostante la sua elevazione, era un uomo e soggetto alle necessità della natura. Oggi, molti studiosi ritengono che il riferimento alla leggenda della papessa Giovanna sia stato frutto della fantasia medievale, ma il solo fatto che l’oggetto sia giunto fino a noi e custodito nel chiostro del Laterano, lo rende testimone di un’epoca in cui sacro e superstizione si intrecciavano indissolubilmente.
Il ballo dei poveretti-San Marco Evangelista
In passato dinanzi alla basilica San Marco si tenevano diverse manifestazioni popolaresche, come il ballo de li poveretti che aveva luogo ogni primo di maggio. La festa si svolgeva davanti al simulacro di Madama Lucrezia, una delle famose statue parlanti della vecchia Roma, appoggiato al lato sinistro della chiesa. La statua veniva rivestita di stoffe sgargianti, ornata con diademi di carote, di collane di cipolle, capi d’aglio e peperoncini. Alla festa che culminava con il cosiddetto “ballo dei poveretti” o dei “guitti” prendevano parte popolane e giovanotti dei vari rioni ma anche gobbi, storpi, vecchietti in vena di follie, con grande spasso del popolino.
I Mantelloni del Caravita-San Francesco Saverio del Caravita
Una tradizione religiosa del Seicento era quella che riguardava l'oratorio del Caravita, piccolo luogo di culto dedicato a San Francesco Saverio. L’oratorio prende il nome del suo fondatore, il gesuita Piero Caravita, che lo fece costruire nel 1631. Fu luogo di ritrovo dei “Mantelloni”, com’era popolarmente definita la Congregazione della Santissima Comunione Generale, il cui scopo era quello di favorire la regolare ricezione della comunione durante la Messa. I membri della Congregazione, dopo le funzioni serali, erano soliti fustigarsi all’interno dell’Oratorio come forma di espiazione per i propri peccati, ma accadeva che qualcuno frustava le spalle del vicino anziché le proprie e a quel punto la rissa era spesso inevitabile. Erano così frequenti i parapiglia, che la pratica nel XVIII secolo venne poi sospesa.
Sempre dopo le funzioni serali, avvolti in grandi mantelli neri per cui vennero denominati "Mantelloni” si sparpagliavano per la città, recitando il rosario e giunti sotto un’immagine della Madonna intonavano litanie. Alla fine di queste e di altre preghiere, ciascuno al saluto di Sia lodato Gesù Cristo rispondeva Sempre sia Lodato, e se ne ritornavano alle loro case.
Il Cristo della Scala Santa-San Lorenzo in Palatio
Il termine “acheropita” viene dal greco e indica una pittura “non realizzata da mano umana”. A Roma una delle opere acheropite più venerate è il Redentore che si trova nel Sancta Sanctorum in cima alla Scala Santa in San Lorenzo in Palatio.
La tradizione vuole che dopo l’ascesa in cielo di Gesù la Vergine Maria e gli Apostoli abbiano chiesto a S. Luca, medico e pittore, di realizzare un dipinto in cui fosse raffigurato il volto del Cristo. S. Luca aveva accettato il compito ma, mentre stava per iniziare il suo lavoro, il dipinto si materializzò sulla tavola, si dice per opera degli angeli. In realtà l’icona, ricoperta da una lamina argentea, è databile tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo: nei secoli passati al mattino di Pasqua i Pontefici si recavano nel "Sancta Sanctorum" per assistere all' Anastasis, l'apertura delle ante che chiudevano l'icona, un rito che evocava l'uscita di Cristo dal sepolcro. Inoltre, nella notte del 14 agosto, alla vigilia della solennità dell'Assunta, per rappresentare scenograficamente la “Dormitio Virginis”, ossia l’incontro di Maria con Cristo nel momento della sua morte, prima dell’Assunzione. L’immagine del Salvatore veniva condotta in processione fino alla basilica di Santa Maria Maggiore dove, alle prime luci dell'alba, avveniva l'incontro con l'icona della “Salus Populi Romani”.